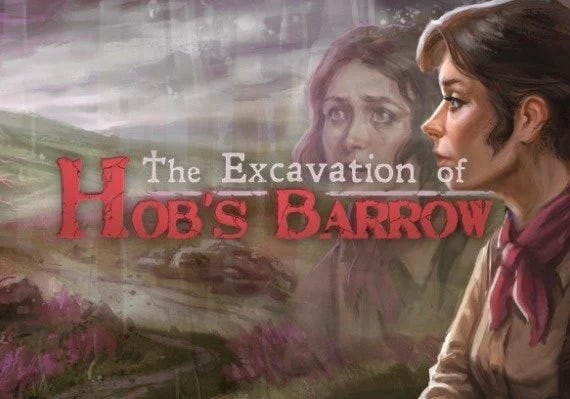Giochi del Piffero: The Excavation of Hob's Barrow
Folk horror, discesa agli inferi e vestigia del videogioco che fu
Qui un piccolo manifesto della rubrica Giochi del Piffero. Essa si oppone strenuamente all’ossessione contemporanea per gli spoiler: potrebbero sempre essercene, perciò occhio.
La mia ricerca di nuove soddisfazioni nelle lande dei giochi narrativi — che mi ha visto passare, fra le altre, per la delusione neppure amara, solo stanca, di Return to Monkey Island — mi ha portato tra le braccia di diverse avventure grafiche, un genere che considero tutto sommato fallato alla base ma nel cui rinnovamento non so smettere di sperare. Tra queste mi ha colpito particolarmente quest’anno (ma l’uscita è del '22) The Excavation of Hob’s Barrow, di Cloak and Dagger Games e distribuito da una delle più significative insegne dell’avventura grafica di oggi: la Wadjet Eye di Dave Gilbert, che imparai a conoscere con la serie di Blackwell (la quale sarà storia, forse, per un altro giorno). Il distributore è specializzato in avventure punta e clicca e sempre, in qualche misura, nostalgiche, o perlomeno orientate a conservare qualche organo vestigiale risalente al periodo d’oro del genere, quei primi anni '90 del duopolio Lucas e Sierra che fatichiamo tanto a scrollarci di dosso. The Excavation (mi concedo di abbreviare) in particolare è stato scritto da due persone, Shaun Aitcheson e Laurie MH, che alla nostalgia per il filone hanno voluto unire la passione per il folk horror britannico e per l’opera di Lovecraft. Si capisce bene che non potevo che buttarmici a pesce.

L’ambientazione è dunque vittoriana e britannica, l’ispirazione strutturale è invece la tarda avventura della Sierra, in una curiosa commistione tra una pixel art che omaggia quella storica e un’interfaccia memore invece delle ultime avventure della casa, quelle con green screen e attori, o piuttosto delle successive avventure di Jane Jensen (Gray Matter e Moebius su tutte): per cui c’è solo un tasto per agire con l’oggetto o il personaggio puntati (marcati con testo), uno per esaminare, e un inventario a trascinamento (nonché a scomparsa). Anche la struttura è pienamente sierresca, con l’articolazione dell’avventura in giornate e avvenimenti diversi negli stessi luoghi innescati da diversi trigger; ma con in più delle aggiunte da “qualità della vita” tratte dall’origine nascosta del genere (lo so, mi ripeto), ovvero l’RPG: così abbiamo un elenco di obiettivi da conseguire (ottimo se si riprende l’avventura a distanza di tempo) e un elenco dei luoghi principali con navigazione rapida a corredo. Non manca la presenza di azioni del tutto opzionali ma che approfondiscono meglio la storia, anche se, a differenza dei capostipiti, non c’è alcun sistema di punteggio collegato (facendone le veci il sistema di obiettivi, giustamente).
Non ci addentriamo troppo nelle vicende dell’archeologa Thomasina Bateman, dedita allo scavo di un tumulo del paesello rurale di Bewlay in cui sono riposti segreti ancestrali intrecciati a fatti di famiglia — mi limito a rilevarne i diversi elementi interessanti. Innanzitutto l’intreccio di flashback dell’infanzia della protagonista e di narrazione a posteriori, con Thomasina che, ad anni di distanza, racconta quel che vediamo accadere lasciando riferimenti sibillini all’esito. Intrigante è poi l’ispirazione a un luogo reale, ovvero Hob Hurst's House, un tumulo dell’età del bronzo situato nel Derbyshire. Ma ancora più intriganti sono i nuclei tematici: Thomasina ci appare schiacciata dal rapporto col padre, archeologo di fama costretto da anni in un letto d’ospedale da un male misterioso, alla cui causa lei resta però votata; il tutto intrecciato al mistero del tumulo, a qualcosa che alligna tra gli abitanti di Bewlay (che per lo più cercano di ostacolare l’eroina, con apparenti, e sempre ambigue, eccezioni) e a qualcosa che cova in lei stessa.
Il gioco mi ha però sorpreso soprattutto per l’estrema coerenza che è riuscito a creare tra racconto e design, giocando coi limiti di quest’ultimo: gli autori, consapevolmente o meno, hanno saputo torcere i limiti intrinseci a un’avventura grafica di interfaccia moderna — i vincoli fortissimi all’interazione, degni di un edutainment — e usarli per rappresentare l’inesorabilità della spirale discendente di Thomasina: muovendo il puntatore che ne rappresenta la percezione non ci è consentito fare caso a degli elementi sospetti che pure sono ben presenti a video (mai, mai ci è dato di esaminare dei significativi simboli appesi alle pareti, che si riveleranno cruciali), e laddove il gioco non ci lascia mai davvero bloccati fino all’ultimo (è una delle pochissime avventure cui abbia mia giocato che non mi ha mai indotto nella tentazione di guardare una guida) incontriamo degli enigmi combinatori di stampo classico solo nel finale, in un regno improbabile in cui meritatamente stanno: il mondo sotto al tumulo, dominato dal colore rosato proprio del fiore allucinogeno noto come elleboro1.
Purtroppo il gioco, come moltissimi titoli indie dei più significativi di oggi, si perde nell’omaggio ai capostipiti oltre quel che sarebbe utile, e a tratti stordisce il suo svolgimento con enigmi vecchio stampo nemmeno difficili, ma solo di troppo e fastidiosi — per quale diamine di ragione al mondo dobbiamo strappare dei crini a un cavallo per sistemare un archetto di violino alla bell’e meglio, quando nella realtà non si può nemmeno fare senza attrezzi da liuteria? Che falsa nota! Il che non toglie che in ultimo ha saputo prendermi tanto da farmi letteralmente far notte, e nonostante mi fossi spoilerato il finale.
La carica disturbante del gioco è ben rimarcata da una critica fatta da diversi giocatori in giro per la rete: in molti hanno lamentato l’assenza di una scelta morale alla fine; dover accompagnare Thomasina nella sua discesa al tormento tanto li ha turbati che avrebbero voluto risparmiargliela. La critica è, beninteso, fuori fuoco; chi l’ha posta non ha colto quel che il gioco si è adoperato per fare, l’amarezza che queste persone hanno provato è il perfetto compimento della vicenda e non posso che elogiare i creatori per non averle dato seguito con qualche patch infame. Eppure è emblematica di quanto il gioco si è rivelato efficace e coraggioso2. Senza quelle vestigia della vecchia, farraginosa avventura di una volta, sarebbe davvero stata grande. Così com’è, è comunque un gran passo nella direzione giusta.
Sì, è per questo gioco che ho messo la foto di un elleboro quando presentai la rubrica. Se avevate indovinato, sappiate che non si vince neppur un corno.
Nonché di quanto il gioco di ruolo alla BioWare abbia devastato il palato dei giocatori, con quel suo binarismo orrendo. Non potevo chiudere senza polemica, lo sapete.