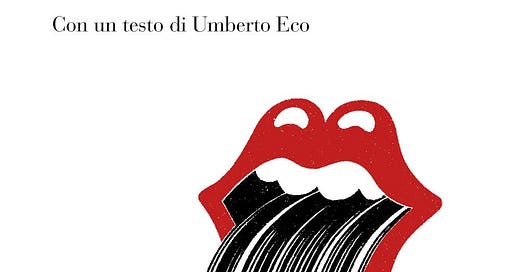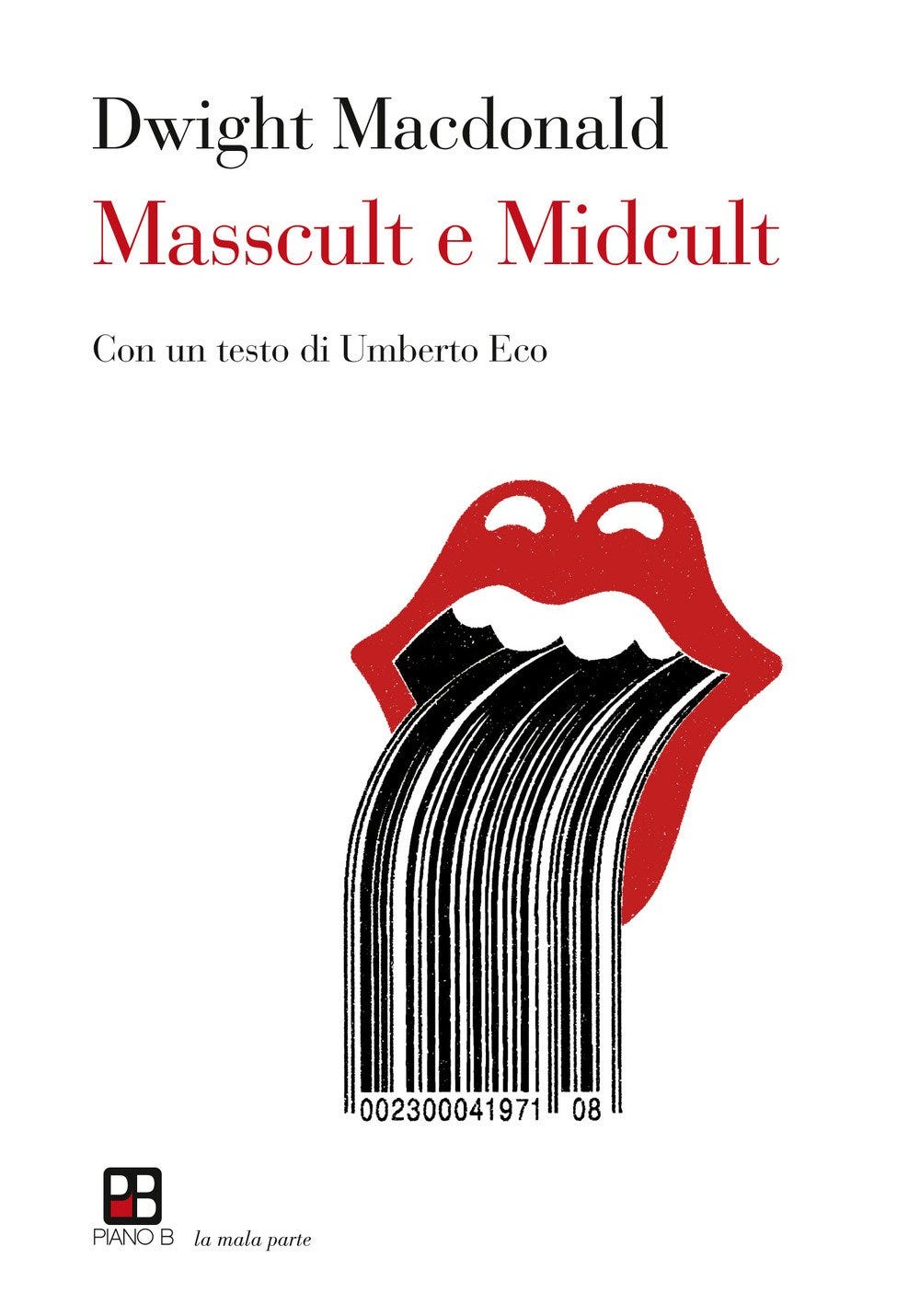Libri del Piffero: "Masscult e Midcult" di Dwight Macdonald
È davvero ora di fare questo discorso
Nella rubrica Libri del Piffero vi racconto saggi su (o intorno a) estetica, musicologia, storia della musica e dello spettacolo, le relative industrie, editoria; o anche la biografia di qualche personaggio o gruppo — e condivido con voi le considerazioni che so trarne.
Nella newsletter cito sempre il midcult come qualcosa di biasimevole, una sorta di universale nota di demerito entro i miei parametri estetici, senza preoccupazioni definitorie. Solo una volta mi è stato chiesto che cosa intendessi con la parola, che sia perché non la uso effettivamente un granché spesso, o perché in qualche modo intimidisco i lettori. Comunque mi sembra importante finalmente chiarire che cosa intendo, perché sia chiaro anche come valuto le cose — un lavoro che avrei dovuto fare ben prima a ben vedere, ma io stesso sto andando con la corrente; il solo modo in cui riesco a fare le cose senza che l’analisi si faccia paralisi.
Avendo aperto la rubrica dei Libri del Piffero (che ha esordito col botto grazie al Maestro Aaron Copland, date un’occhiata se non l’avete fatto!), nulla di meglio che recuperare il libriccino da cui ho tratto il concetto, per parlare un po’ di come l’ho rivisitato. Eccoci quindi a Masscult e Midcult, piccolo pamphlet di Dwight Macdonald, intellettuale socialista e poi anarchico dedito ad attività che oggi definiremmo di “critica culturale”, attivo dal 1937 alla sua morte nel 1982, che scrisse tale celebre tirata in vista di una pubblicazione su rivista, precisamente sul Saturday Evening Post: la cosa non si fece per problemi di “linea editoriale” (come racconta Macdonald stesso in un’estesa nota) e il tutto uscì come libello nel 1960, in un contesto mediatico quindi profondamente diverso da quello di oggi.
Qui faremo riferimento alla recente edizione italiana di Piano B (2018) di cui all’immagine in testa, a cura di Mauro Maraschi e corredata con “un testo di Umberto Eco” che altro non è che un assemblaggio di considerazioni tratte da Apocalittici e Integrati buttato un po’ così a formare una specie di postfazione mai nata (Vanni Codeluppi nella sua recensione su Doppiozero critica la scelta aspramente, e sono in sostanza d’accordo). È un’edizione comunque fresca e facilmente reperibile di un libello di un centinaio di pagine, di cui potete abbeverarvi in un mezzo pomeriggio.
In sintesi, Macdonald scrive un libro densissimo che muove da un retroterra culturale sostanzialmente di sinistra e asistematico (con Theodor Adorno sempre sullo sfondo), democratico ancorché snob, per definire il Masscult compiutamente e arrivare poi al vero succo: la definizione dell’emergente Midcult, fenomeno a suo dire del tutto nuovo e deteriore, che si profilava proprio allora e che egli trovava urgente definire. Ma andiamo con ordine.
Sul Masscult è presto detto: si tratta di produzione artistica (diremmo mediatica, oggi) che non chiede nulla ed è distrazione, nemmeno intrattenimento (che implica un coinvolgimento), in contrasto con la cultura alta (come la chiama lui e come la chiameremo in seguito) che non è sempre riuscita, ma ma induce sempre a pensare molto, esprime idee contrastanti. Macdonald innesta l’idea sulla teoria, allora praticamente classica, dell'uomo di massa come prodotto della distruzione delle comunità, e della massa come “disorganica e poco creativa”, il cui gusto inclina al minimo comun denominatore. Macdonald pone anche il classico problema “dell’uovo e della gallina”, sostenendo senz’altro che il pubblico desidera il Masscult perché conosce quello, credendo indefessamente nella potenzialità della gente ordinaria (condivido). Il riferimento è alla Hollywood di allora, con un giudizio viziato quindi dal panorama asfittico di allora, quando la cosiddetta New Hollywood ancora non si vedeva (e del tutto simile a quello di oggi, se chiedete a me). Il Masscult, prosegue Macdonald, si pone come forza rivoluzionaria, che abbatte le distinzioni col pretesto dell'educazione (ah, l’educazione, mia bête noire!). Ne sono esempi, oltre ai film, riviste generaliste come Life, con la loro tendenza ad accostare di tutto senza costrutto.
Seguono considerazioni giunte nel dibattito pubblico italiano, mi vien da dire, soprattutto attraverso Pasolini: Se prima la cultura alta si distingueva dall’arte popolare, proveniente dal basso e latrice comunque di istanze genuine, il Masscult, diremmo oggi, è top-down: fatto da tecnici che procedono per tentativi (e oggi per algoritmi). Curiosi ed eloquenti gli esempi di Macdonald, che classifica positivamente come popolare il jazz mentre biasima il rock’n’roll — una di molte, divertentissime istanze in cui vediamo la storia ripetere sé stessa —, che avrebbe conseguito credibilità critica sostanzialmente a British invasion inoltrata1, quindi ben dopo l’uscita del saggio. L’autore peraltro denuncia già allora il basso livello delle recensioni nella stampa commerciale, prendendosela soprattutto col critico di cinema, che omette il proprio gusto personale, il che per lui è un problema2.
Le origini del Masscult, scrive Macdonald, sono in realtà più remote di quanto si sospetti normalmente: risalirebbero infatti all’Inghilterra del XVIII secolo, con la diffusione su larga scala della stampa. Intorno al 1790 finì la tradizione orale delle fiabe (Dwight, ma anche no!) perché tutti leggevano, e la robaccia incrementò di conseguenza. Già allora assistiamo a un crollo degli standard, con la diffusione del romanzo moderno, spesso molto scadente — oggi Macdonald osserverebbe forse che tutti sono lettori, ma pochi sono lettori di libri. Macdoland situa l’origine del Masscult in figure in realtà blasonate, come Alexander Pope e Lord Byron, denunciando il romanticismo e la sua tendenza a vendere un personaggio prima che un autore; paradigmatico è poi Walter Scott, prototipo dell’autore “catena di montaggio” e della pressione produttiva in letteratura, non sempre premiata dal pubblico e, a giudizio di Macdonald, dovuta specialmente al gusto degradato di editori e produttori (ricorda niente, tipo qualche dibattito molto recente?). Per lui è propriamente democratico presupporre sempre l’intelligenza del fruitore, e non pensare all’“ipotetico idiota” cui pensano gli impresari, in ispecie, secondo lui, quelli americani.
Il Masscult passa quindi a offrire il surrogato di un rapporto umano, attraverso degli autori condannati a ripetersi o a dei personaggi, per distrarre un individuo “isolato e spossato”, instaurando un rapporto di amore-odio verso il genio personale o individui molto carismatici, che tendono a non stare al gioco, con quel ciclo infinito di biasimo per chi devia e si distingue salvo lamentarsi di chi si ripete (mi ripeterò spesso: ricorda niente?)3 — un ciclo, dico io, apparentemente immutato da 60 anni e rotti, e che mi ha consolidato nella mia convinzione del fan(atic) come creatura sofferente in sé. L'autore Masscult, prosegue l’autore, ha in comune molto con l'uomo comune (il che lo rende capace di intercettarlo), salvo che tende a credersela molto di più. In USA in particolare la svolta si ha con la guerra civile, che porta alla sparizione della cultura del New England e a ondate di immigrazione che non sono riuscite a produrre un vero pluralismo, ma piuttosto al melting pot visto negativamente, come assimilazione delle culture di ingresso tramite il kitsch (qui io ci vedo un criptorazzismo che nessuno mi toglie dalla testa essere presente nella teoria adorniana, sbaglierò).
In reazione a tutto ciò nasce l’avanguardia, uno sforzo di recupero della tradizione che preservi la cultura alta, e in contrasto a essa l’accademismo, concentrato più sulla maniera. La cosa si innesta nel particolare panorama americano, dove la distinzione di classe è meno netta che in Europa (o almeno, la era allora…), e la società, a partire dal '45, è caratterizzata da un ceto medio espanso; così che molte persone si trovano a non sapere cosa scegliere, per fare un esempio, fra Tolstoj e una detective story. Concedendo che per alcune persone questa scelta è in effetti stimolante, l’autore tuttavia vede in tale incertezza il brodo di coltura del suo mostro: il Midcult, appunto.
Che cos’è dunque questo Midcult? per Macdonald, è una forma di produzione culturale che ha TUTTE le caratteristiche del Masscult, ma aggiunge un pezzo fondamentale:
Nel Masscult il trucco è scoperto: piacere al pubblico con ogni mezzo. Il Midcult, invece, attira il pubblico in due modi diversi: da un lato finge di rispettare i canoni della Cultura Alta, dall’altro, a conti fatti, li annacqua e li volgarizza.
Macdonald fa molti esempi di Midcult oggi giocoforza poco noti, da riviste di divulgazione come Horizon a un’allora famosa edizione riveduta della Bibbia di Re Giacomo, che si poneva l’obiettivo di renderla più facile da leggere (ricorda niente?). Ad ogni modo Macdonald si sforza di individuare vari caratteri precipui del midcult, sintetizzandoli in alcune stroncature mirate (la più celebre delle quali è senz’altro quella de Il vecchio e il mare di Hemingway): il lirismo d’accatto, le mille esplicitazioni che non lasciano alcun non detto (io lo chiamo didascalismo, in contrasto con la cultura alta che induce a pensare proprio producendo contrasti), la teologia spicciola, l’esaltazione della vita dei piccoli centri, i personaggi arguti e sentenziosi, l’amore che salverà il mondo in astratto salvo che nella vicenda nessuno si ama, la spocchia verso una classe di intellettuali disprezzata ma sempre tenuta a mente; la psicanalisi popolarizzata (rivedo così tanti esempi recenti di tutti questi punti che mi scappa da ridere); e una visione generale dell’autore come meritorio per il suo mero credere in ciò che fa.
Il contrasto tra fede (bene) e abilità (male) è tipico del Midcult, come lo è l'accettazione del moralismo progressista quale soddisfacente surrogato del talento
Il tutto assimilando le avanguardie, distinguendosi dalla maniera dell’accademismo che invece le contrastava. E mirando al pubblico educated, quello delle università (ricorda niente?). Se il Masscult distrugge i canoni e rende impossibile l’ascesa delle classi emergenti, il Midcult si fa canone impoverito, e di conseguenza è più subdolo, e pericoloso, del suo antesignano. Il Midcult è conformista, contro l’avanguardia che è snob ma aperta, riconoscendo l’importanza dei canoni e stando sul filo tra conservatorismo e rivoluzione. Arrivati al presente del libro, l’avanguardista si trova isolato, con action painters e beatnik che risultano eccentrici, non continuatori di una tradizione, con un pubblico incompetente e da stupire di continuo4; mentre il Midcult dilaga. Se c’è molta cultura alta per le masse grazie ai nuovi media, essa risulta passiva, di risulta, sempre filtrata dall’approvazione delle autorità.
Macdonald chiude su una nota pessimista: per lui non ci sono ricette facili per contrastare il Midcult, né il controconservatorismo di Eliot e Ortega y Gasset — per cui la distinzione tra cultura alta e bassa va ripristinata e punto; ma non è più possibile nell’ecologia della comunicazione attuale — né il progressismo marxista — per cui il Masscult è una forza positiva e va solo migliorato; ma resta ineludibile il problema che proviene dall’alto e non è espressione popolare —, e sostiene piuttosto che qualcosa si possa fare suddividendo il pubblico in una pluralità di pubblici, prevenendo la tendenza verso il minimo comun denominatore. E qui vediamo già preconizzata l’attuale frammentazione, che alcuni considerano più che altro benvenuta (eccomi qui) mentre altri lamentano la progressiva dissoluzione di una cultura condivisa con le divisioni che ne conseguono (salvo altre considerazioni, mi preme ricordare loro quanto usavano lamentarsene quando c’era. A me, pur riconoscendo alcuni pericoli, ciò sa molto di rimpianto per un’egemonia non più in vista, ma a ognuno il suo).
È il momento di tirare le somme e dire qualcosa in più. Il saggio è davvero denso — sono anche andato più in dettaglio del mio solito nel riassumervelo — e per quanto interessante nell’individuare molte cose di cui si parla ancora oggi, e quindi utile a curare un po’ del presentismo cronico del dibattito, pure è alquanto disordinato e fin troppo snob, prestandosi a molte obiezioni: ne ho avanzate alcune e se ne possono fare molte altre, fra cui quella del curatore stesso dell’edizione, che non può non osservare che il saggio stesso era destinato a una rivista generalista, ed è in sé un prodotto midcult. Si potrebbe dire anche che individuare il Midcult e distinguerlo da prodotti più elevati o genuini non è poi così ovvio come Macdonald sembra dire; e che molte sue considerazioni sono da rivedere ampiamente alla luce del panorama mediatico di oggi, con la rete, lo streaming e il regime di abbondanza che ne derivano, il Masscult a regime minimo e la sua frammentazione, e l’ondata di poptimism a confondere ulteriormente il quadro. Ma questo è terreno per riflessioni che, confesso, non ho per niente messo a punto.
Tuttavia la nozione di Midcult, la prima volta che la incontrai, mi risuonò in modo particolare: provengo da una giovinezza cerebrale e nevrotica, caratterizzata da una costante caccia di stimoli entro un regime di austerità e repressione autoimposte e formidabili e da una fame di verità inesauribile; e se pure mi divertivo con videogiochi, dischi e letture anche leggere, sviluppai una precocissima repulsione per la stampa generalista e per tutto ciò che mi veniva presentato come doveroso da leggere per essere sul pezzo. Ricordo distintamente come, dopo essermi fatto avvitare la mia povera testa con Cervantes, classici densi come Spinoza o Pascal o le estenuanti interrogazioni di Jiddu Krishnamurti, una volta presa in mano una rivista sui fatti del mondo la sua vuotezza di fondo mi desse le vertigini; ogni tentativo fatto in una sala d’aspetto mi faceva ritirare nauseato. Ricordo distintamente come il film del momento, con tanti oscar sul groppone, mi ispirasse diffidenza più spesso che no e finisse sempre per deludermi con le sue formule e per irritarmi col suo prendermi per scemo (non sempre confessandolo, neppure a me stesso, perché tutti da giovani cerchiamo un po’ di approvazione; ma comunque). In fondo sono sempre stato uno snobbone nato, portato al piombo e alla piuma, a leggere i grandi classici e a ridere coi filmacci; e in ambito musicale, se divenni un progster (oggi non tanto, ma iniziai così) fu giusto perché il prog mi sembrava più variato e, di conseguenza, divertente di molte delle alternative. E se, come molti studenti, mi allontanai dalla narrativa per molti anni, mi rifeci in età adulta con una risma di Urania.
Non sapevo come definire questo approccio, benché sentissi l’urgenza di farlo, finché non mi imbattei nell’idea delle strategie barbell, o “a bilanciere”, che consistono nel concentrarsi sugli estremi di uno spettro trascurando il mezzo; e soprattutto nella loro applicabilità alla cultura: classico e sperimentazione, nozioni dure e leggerezza, tenendo conto della necessità di entrambe le sponde (una mente allenata deve anche distendersi, e una mente distesa deve anche raccogliere — un equilibrio che mi ha preso molto tempo) e ignorando il più possibile ciò che è di cultura media, che è risaputo, conferma, non dà vera gioia né riposo, né eleva. In questo quadro ho integrato il midcult come l’Avversario, l’essere proteiforme da indagare per evitarlo, come in un percorso di santità che come tale è asintotico, consapevole che il midcult è ovunque e che, come tutti, ho una tendenza più o meno forte a caderci. E consapevole che, se il midcult non è così facilmente individuabile come Macdonald sembrava pretendere, pure tenerlo a mente ha un valore euristico enorme: ognuno, ritengo, deve crearsi una propria dieta anche trovando il proprio midcult e i propri antidoti a esso.
Così, in musica evito come la morte stessa la nuova ondata neoclassica, l’indie affetto da cachessia che pretende di redimersi col “messaggio”, e guardo sempre al cantautorato con diffidenza; quanto alle letture evito i manuali di auto-aiuto o le trattazioni accattivanti del tema del momento, così come i vaniloquenti trattati sul Grande Tutto o sul futuro dell’umanità e i romanzetti “di nessun genere” e sentimentalisti, e tutto ciò che piace a quella figura letale che è il “cittadino ben informato”, che si riempie di nozioni per trovarsi poi capacità predittive inferiori a quelle che avrebbe non avesse letto nulla (corollario: niente giornali e niente notiziari. Che, scherziamo?). Via invece a classici, a saggi su temi affrontati scientificamente e a romanzetti divertenti. E se non avessi del tutto rinunciato alle serie per questioni di tempo, mi terrei bene alla larga da quelle più intelligenti e verbose, che poi sono anche le più diluite.
Certo questo passa per il disdegno di grosse porzioni del canone condiviso in società, per avere il coraggio di affrontarne le conseguenze (ma non ne serve così tanto, in realtà), ed è una prospettiva radicalmente antiborghese; del resto Macdonald era un anarchico e io anche, e so di proporre un quadro un po’ libertario e un po’ reazionario. Ma se noi libertari e reazionari abbiamo ragione, io che ci posso mai fare?
Su questi principi, un pezzo alla volta, ho orientato questa newsletter, in cui vi parlo del folk (con cui mi gaso tanto perché è un vero e continuo spasso. E perché, se no?), delle frange, di proposte personali e artigiane o, se non quello, perlomeno col pregio della levità; e in parallelo vi mostro i legami con la musica antica e l’avanguardia, affastellando i due mondi per un completo godimento — il tutto volando intorno al mio gusto personale, e con una sistematizzazione sempre in fermentazione e in divenire; ma con una proposta che credo possa incontrare, ogni tanto, la curiosità di più di qualcuno.
Questa è la mia modesta proposta, più artistica e improvvisata che critica, per voi — e spero di avervela chiarita nel consigliarvi questo libello. Adesso invece sto rileggendo I racconti di Canterbury, perché la presa sui classici non va mai mollata. Mai.
Bene, è tutto; per obiezioni, pensieri e richieste ci possiamo scrivere nei commenti o rispondendo alla mail. In ogni caso, vi aspetto alla prossima con un nuovo riepilogo.
Il pubblico rock a tutt’oggi inclina a condividere un canone che parte proprio da lì, col 1962 o giù di lì come un ideale anno zero — e non è un caso.
Sono d’accordo, e infatti è per questo che lo metto sempre avanti — a costo di rinunciare alla patente di critico, che in effetti non m’interessa.
A questo punto Macdonald mostra la sua tendenza a una teoria forte del talento: il bravo artista, se è davvero tale, non può non mettere sé stesso, persino quando fa kitsch. Ciò apre, senza risolverla affatto, l’annosissima questione dell’autenticità. Conto di tornarci.
Interessante nella sua apparente ovvietà l’osservazione che Macdonald fa a questo punto: il pubblico delle arti è spesso incompetente, a differenza di quello sportivo. Anche interessante, e molto meno ovvia, l’osservazione per cui, secondo lui, gli americani tendono a un eccesso di specializzazione, contro una positiva capacità degli europei di conservare una dimensione artigiana ed essere più generalisti, dei polymath (una cosa che oggi, a quanto vedo, molti americani continuano a vedere e apprezzare).