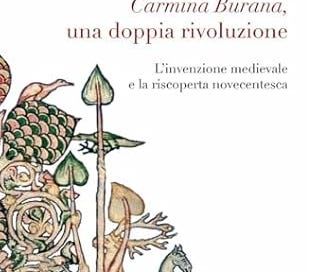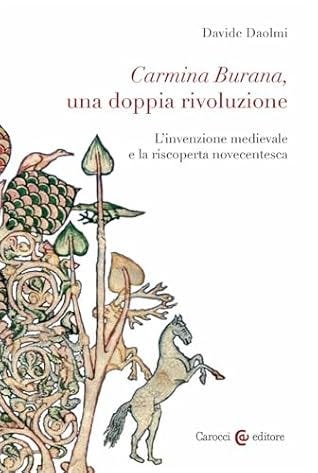Nella rubrica Libri del Piffero vi racconto saggi su (o intorno a) estetica, musicologia, storia della musica e dello spettacolo, le relative industrie, editoria; o anche la biografia di qualche personaggio o gruppo — e condivido con voi le considerazioni che so trarne.
Rieccoci coi libri dopo tanto tempo! Avrei voluto proseguire la rubrica con cadenza suppergiù mensile, quindi uscire sul finire di aprile; ma il lungo ponte primaverile si è messo di mezzo e in seguito, tra concerti e uscite tanto attese, non sono più riuscito a trovare un buco in cui mettercela fino a ora. Nel mentre sono riuscito a finire un altro libro dopo quello di cui vi dico stavolta e sono a buon punto con un altro ancora; il che non mi spiace, visto che la sto trovando una rubrica alquanto impegnativa e un po’ di respiro per occuparmene non guasta. Ma non indugiamo oltre.
In questa prima fase sto cercando di coprire generi di libro diversi per mostrare la gamma cui voglio dedicare la rubrica — così, dopo la guida all’ascolto di Aaron Copland e la tirata estetica di Dwight MacDonald che mi portò su un’erta senza ritorno, ora passiamo a un testo storico-musicologico, con fior di parti tecniche.
Si tratta di Carmina Burana, una doppia rivoluzione: L’invenzione medievale e la riscoperta novecentesca, un libro cui accennai qui sulla newsletter più di un anno fa, allorquando avevo assistito alla sua presentazione accompagnata dall’ensemble Murmur Mori. L’autore Davide Daolmi è professore associato di Storia delle teorie musicali e Storia della musica medioevale e rinascimentale nell’Università degli Studi di Milano, e ha scritto anche il primo volume di una Storia della musica che ho messo in lista e leggerò, presumo, verso le calende greche. Questo saggio ha un oggetto ben preciso: i Carmina Burana appunto, e il libro manoscritto da cui sono stati tratti, il cosiddetto Codex Buranus, e del suo enorme impatto sulla musica del Novecento e di oggi.
È bene chiarire subito che, a onta di una relativa leggerezza della prosa, si tratta di un testo accademico a pieno titolo, destinato a chi ha un’infarinatura di musica medievale e della complessa storia della notazione musicale (e non ho problemi a confessare di aver sofferto, leggendolo, il possesso di un retroterra insufficiente). La struttura riflette tale indirizzo, con una compartimentazione dei contenuti che fa sì che non si debba per forza leggerlo da capo a fondo: segnatamente abbiamo quattro capitoli sulla storia esecutiva dei Carmina Burana e tre intermezzi fra un capitolo e l’altro che approfondiscono la storia del manoscritto, la sua composizione e la sua struttura. Non trovo di meglio che tracciare i contorni del libro proprio a partire da tale struttura.
Il primo capitolo si occupa dei Carmina Burana di Carl Orff: presentate per la prima volta nel 1937, associate all’estetica del Terzo Reich (un po’ a sproposito, a detta di Daolmi) e senza alcunché di medievale, e che hanno dato inizio da un lato a un nuovo immaginario medievale gremito di anacronismi musicali, dall’altro al cosiddetto Early Music revival, alla base della mia amatissima scena folk e, secondo Daolmi, addirittura il movimento musicale più importante del secondo Novecento insieme al rock (!). L’autore si dilunga sia sul modo in cui Orff ha scoperto il manoscritto, sia sulla ricezione critica delle sue composizioni (sulle prime tiepida o peggio, in realtà; al contrario di quella del pubblico) e su come la nostra idea di “Medioevo gotico” si sia modellato su di esse.
Seguono il primo intermezzo, sulla struttura del Codex Buranus, e il secondo capitolo sulla sua storia: si tratta del primo canzoniere di cui siamo a conoscenza, e ha origine — ciò è acclarato, per Daolmi — nel monastero di Novacella, presso Bressanone, in Alto Adige; e deve il nome di Buranus al monastero di Benediktbeuern in Baviera dov’è stato ritrovato nell’Ottocento. Il Passo del Brennero, al confine con la marca travigiana, è anche il luogo di nascita delle raccolte trobadoriche, e la sede principe delle interazioni culturali volute da Federico II di Svevia. Risalente al Duecento, il codice comprende canzoni spesso ancora in latino, di argomento profano e non sempre cortese, e — questa la grande novità — sovente accompagnate dai neumi, l’antico sistema di note non poste in righi o spazi che davano un’idea della melodia da eseguire. Inoltre fa da cerniera tra la tradizione latina, e un po’ decaduta, e l’allora emergente tradizione colta in volgare. Sono tre le urgenze che guidano la trascrizione della musica su libro: la presa di coscienza di un mondo musicale al fuori della liturgia; la produzione di quel volgare “nobile” che abbisogna di una propria lirica per nobilitarsi; e il desiderio delle élite di preservare la propria memoria. Il Codex corrisponde alle prime due di queste fasi, con la terza che si innescherà solo col decadimento della tradizione provenzale a partire dalla crociata albigese. Il Codex contiene finanche testi teatrali, che sono forse la matrice stessa del canzoniere, dato che i drammi dell’epoca erano fatti di canzoni1. La “doppia rivoluzione” del titolo sta appunto da un lato nella produzione di un canzoniere, dall’altro nello sforzo di fermare su carta la musica, se non un repertorio intero.
Il secondo intermezzo è su “Goliardi, poeti e trovatori”: qui Daolmi tiene a sottolineare che la lirica classica non è un modello dei canzonieri, e che la dimensione dei trovatori era performativa, oltre a fare un po’ di debunking sull’immagine del goliarda, per come lo conosciamo di fatto un’invenzione ottocentesca — in altre parole, i goliardi intesi come girovaghi accademici con una propria corrente letteraria non sono di fatto mai esistiti.
Il terzo capitolo è sul materiale del Codex visto dal punto di vista formale: si nota innanzitutto nei testi liturgici l’uso di interlinee molto divaricate, che danno spazio ai numerosi melismi. L’assemblaggio passa poi a comprendere brani di svago e meno melismatici — dice Daolmi, proprio questa organizzazione del materiale secondo la musica più che secondo il tema fa del libro il primo canzoniere —; ad ogni modo si possono riconoscere cinque categorie tematiche: Moralia e Amatoria sono ovvi, e vi si aggiungono Didascalica (storie esemplari, antiche o di vicende amorose in contesti leggendari) e Contrafacta (riutilizzi di musica preesistente con testi sostitutivi) da tedesco a latino — molto del materiale scelto da Orff fa proprio parte di questi ultimi, che sono anche i brani più disimpegnati e originali, oltre che quelli che più si associano ai Carmina Burana in generale nell’immaginario comune. Si finisce poi coi Potatoria, brani conviviali sul tema del bere. Lo scopo sembra essere proprio quello di unire diversi mondi: Daolmi sottolinea come questa varietà formale, oltre a venire codificata proprio in un XII secolo fatto di trovatori, teatro musicale e affermazione del volgare (nonché della nascita della forma sequenza in campo sacro e della forma mottetto in campo profano) sia stata anche vittima di un’ingessatura propria dell’archeologia del suono, con la musicologia di inizio Novecento che associava il medioevo in genere a un suono ieratico e impersonale, che non sembra però davvero trovare riscontro. Di fatto il Codex testimonia di un’epoca preparatoria, distinta dalle epoche classiche in cui si tende a lavorare sulle forme consolidate (un po’ come l’epoca in cui ci troviamo oggi, a voler vedere). Le canzoni profane sono influenzate dalle influenze di quei secoli di rinascimento: appaiono canzoni amorose a tema naturalistico, (A globo veteri), uno sguardo perlomeno indulgente sui membri di altre fedi (Nomen a solemnibus), critiche all’avidità della Chiesa (Utar contra vitia), riflesso di una società più razionale e controllata di quella precedente, in cui la canzone è una forma di informazione circolante, come tale un veicolo fondamentale di diffusione della cultura.
Il terzo intermezzo, insieme al terzo capitolo, costituisce la parte più tecnica del libro, trattando del passaggio dal metro al ritmo come viene documentato nel Codex, con gli accenti trattati con dovizia di illustrazioni. In questa parte si definisce la forma come la struttura che organizza il tempo, lo stile come un complesso di soluzioni ricorrenti, caratteristiche riproposte e paragonabili ad altre2; e il genere come un perimetro di musiche con prerogative comuni e riconoscibili, interne ed esterne — una categoria che si relaziona più a chi definisce che alla musica in sé (negli studi medievali la principale distinzione per genere si basa sulla lingua, ma per Daolmi non si tratta di una scelta davvero ben motivata). Il Codex testimonia come la forma nel medioevo prevalesse su stile e genere. Le forme che possiamo trovare nel libro comprendono il barform, distinto in un fronte e una sirma (ci si basano le canzoni pop ancora adesso!); brani con strofa a refrain, tipica di alcuni dei brani scelti da Orff come Tempus est iocundum e O mi dilectissima; prose musicate in seguito in cosiddetti modelli continui, che potrebbero essere all’origine del mottetto; e infine, la forma continua si presenta anche con l’aggiunta di un refrain — si parla allora di forma alternata, percepita come popolare. In generale è netta la distinzione tra il tema musicale di un brano, il tropo (modello esplicito, che si esibisce mostrando il miglioramento, presentando ad esempio testi diversi per la stessa melodia), e le parole. Nel medioevo ha poco senso distinguere tra originale e derivazioni; in questo il repertorio del canzoniere somiglia molto al folk anche contemporaneo, che ne condivide anche il carattere tropico (ed è una delle componenti che mi rende adorabile il folk, che si sbarazza di pretese inutili di originalità e di individuazione di presunte figure “di genio” che spesso non sono per niente tali — né del resto ce n’è alcun bisogno).
Il quarto capitolo chiude il libro, è quello più scorrevole e se vogliamo quello più interessante in questa sede, trattando dei “medievalismi d’oggi”, ovvero degli strascichi dei Carmina nel mondo musicale di oggi. Orff è autore di una riscoperta significativa ma rimasta a lungo episodica, anche a causa di una critica successiva che gli fu molto ostile (a differenza del pubblico, che invece lo apprezzò da subito) tendendo ad associare l’opera al nazismo nel cui seno era nata (una scusa per una critica strettamente estetica, in realtà) e a paragonarla alle opere di Wagner, da cui pure si distaccava molto (a titolo personale, mi si è chiarito perché essere folkster mi è sempre parso quasi implicare un’avversione per Wagner che rivendico orgoglioso). Passi successivi del revival sono Noah Greenberg coi suoi nuovi allestimenti del dramma latino del XIII secolo (si veda il Ludus Danielis), gli LP di Thomas Binkley con sforzi di ricostruzione dei Carmina Burana più rigorosi, e la ben nota ventata folk degli anni Sessanta, con Bob Dylan e gli sviluppi che riverbereranno in moltissimo del pop e del rock successivi.
Daolmi passa qui a delle considerazioni sulla natura del revival: ricostruire la storia significa sempre proiettare il presente, e i Carmina offrono una riflessione sull’oggi. Lo stesso Orff desiderava aderire alla rivoluzione conservatrice propria della Repubblica di Weimar da giovane, opponendosi alla crisi della tonalità che caratterizzò le avanguardie. L’idea era quella di ripristinare una concezione del ritmo fisiologica, legata al corpo, alla danza (che poi è la tendenza che avrebbe guadagnato terreno nel Novecento fino a oggi); e a riprendere la ricerca sui timbri e sul ritmo, che sarebbe poi stata trionfante (pensate alla diffusione del concetto di sound…). Il discorso sarebbe stato poi ripreso da Hindemith e dalla sinistra radicale americana, che molto si invaghì di questo medioevo a misura d’uomo. Orff tuttavia non si occupa ancora di folklore né costruisce un vero e proprio revival medievale, i suoi Carmina Burana combinando infatti armonia seicentesca, danza rinascimentale (Orff fece molto per la riscoperta di Claudio Monteverdi) e orchestrazione moderna, ponendo le fondamenta di quella musica pseudomedievale di cui è ancora pieno l’intrattenimento odierno — dalle musiche “fantasy” in genere fino ai palesi anacronismi di colonne sonore come quella di Game of Thrones e quella di Howard Shore per Il Signore degli Anelli3; un grande movimento che prende l’avvio da Excalibur di John Boorman, responsabile della ri-popolarizzazione più recente di Orff.
Qui Daolmi affastella molte interessanti considerazioni: propone ad esempio un’idea del pop come stile sovranazionale e apolitico, derivato dal folk, che a sua volta si sovrappone alla musica antica specialmente profana — le due scene, che tanto amo coprire in questo spazio, condividono oggi la ricerca timbrica e di strumenti particolari oltre a quella linguistica. Anche lo stesso trad irlandese o scozzese esplode nel momento in cui viene considerato un deposito di memoria incorrotta.
Proseguendo la storia recente, gli anni Ottanta e Novanta vedono una reazione negli ambienti musicologici che si oppone a questi tentativi di restauro, ritenendoli inautentici e troppo contaminati da invenzioni — la sensata obiezione di Daolmi è che le fonti originali non sono abbastanza informative per fare musica gradevole sulla sola base di esse, e che dopotutto anche la sonorizzazione delle fonti è una scelta estetica come le altre4. Insomma si ripropone l’eterno problema dell’autenticità, che per Daolmi è un’etichetta che piace alle case discografiche e di poco o nessun interesse per gli studiosi (i quali notano che, in questo contesto, si considera “autentico” semplicemente ciò che è suonato con strumenti antichi e non ha vibrato; o che addirittura è eseguito solo a cappella!); spingendosi a dire che l’autenticità non è nemmeno un oggetto di disputa musicologica, e che semplicemente non esiste. In generale per Daolmi l’intervento creativo è da elogiare, essendo una forma di rievocazione del contesto e, di fatto, l’unico modo di restituire alla vita dei testi che altrimenti nessuno leggerebbe (qui fa riferimento all’ensemble Murmur Mori, che non si fa scrupoli di musicare da zero dei testi senza melodia).
In finale si parla dell’esplosione del folk revival nell’est europeo dopo la caduta del Muro (contrapposto al difficile contesto tedesco, in cui l’accostamento al nazismo è parso ineludibile ancora per un bel pezzo), e all’esplosione delle nicchie grazie al web, col folk promosso sulle piattaforme di streaming come prodotto locale, ed esempi di subculture come il folk paganeggiante e quello di matrice ecologista, toccando i territori della celtica, del goth e dell’ambient. Il Codex Buranus, conclude Daolmi, oggi riflette un’inquietudine propria dell’area germanica, perdurante ancora oggi, dato che le influenze atlantiche lì non vengono ricevute con la stessa disinvoltura che usiamo nel Mediterraneo (che Daolmi giudica più incline alla sottomissione e all’assorbimento delle manifestazioni culturali dominanti5). In questo contesto il medioevo affascina perché sembra contrapporsi alla spersonalizzazione propria della modernità. In generale amiamo riprendere il passato in quanto concluso e dominabile, e non del tutto sottoponibile a logiche economiche — il revival svolge allora una funzione simile a quella che i classici greci e latini avevano per gli umanisti e il medioevo fiabesco aveva per la borghesia del XIX secolo. Il Codex è allora un attivatore della memoria proprio perché è un canzoniere, e nulla come le canzoni dà vita alla memoria attraverso la sua continua rigenerazione. Orff ha innescato tutto ciò, e in questo, conclude Daolmi, sta il suo merito.
Come si vede, una lettura intricata e densa (ho tralasciato molti degli aspetti più strettamente tecnici), latrice di una tesi musicologica forte e che ha saputo chiarirmi molte cose intorno al mio amore per le canzoni e alle radici del mio gusto, o della sua assenza. Consigliato, a patto di considerare che rimane un saggio accademico, con le asperità del caso.
Bene, è tutto. Sono ben lieto di aver finalmente ripreso la rubrica libresca, che conto di riprendere il mese prossimo con un esponente di un genere assai più lieve. Vi aspetto presto con una playlist ricca in brani contemporanei tratti dal Codex Buranus, e per ora vi auguro un buon proseguimento di settimana. Alla prossima!
E si potrebbe sostenere che il musical è una di tante cose in cui il medioevo è tornato nel mondo di oggi.
Nel medioevo, dice Daolmi, si riconoscono stili differenti guardando al testo e contesto; non se ne distinguono invece nelle melodie, riutilizzabili con molta disinvoltura. Gli stili medievali sono collettivi e raggruppabili per affinità — e si è giunti a inventare figure di trovatori mai esistiti nella realtà semplicemente associando brani diversi per stile, tanta era l’urgenza di attribuirli a un autore.
Contro quasi tutta la cultura nerd mondiale, morirò sulla collina in cui si sostiene che la trilogia di Peter Jackson è sì importante da un punto di vista produttivo, ma non costituisce affatto un buon adattamento dell’opera di Tolkien: non da ultimo, per via dei tremendi motivetti in stile “Celti col rosolio in mano” delle musiche di Shore. E non inizio coi problemi che mi dà in media la musica degli RPG su computer…
Qui ho visto un certo chiarimento, ancorché a posteriori ovvio, del perché mi sento sempre alquanto lontano dalla recente mitizzazione degli Ottanta musicali.
Vista da un lato la natura quasi autarchica della scena musicale italiana che tante frustrazioni mi dà da una vita, e dall'altro il facile dominio del pop anglosassone in Germania, avrei delle obiezioni; ma tant’è.